“Noi non troviamo appoggio ed asilo se non nel governo pontificio, e la nostra riconoscenza è grande come il beneficio che riceviamo. Prego Vostra Eminenza di deporne l’omaggio ai piedi del santo Pontefice Pio VII. Parlo in nome di tutta la mia famiglia, e specialmente di colui che muore lentamente su uno scoglio deserto. Sua Santità e Vostra Eminenza sono i soli in Europa che si adoperano per addolcire i suoi mali e che vorrebbero abbreviarne la durata. Ve ne ringrazio tutti e due col mio cuore di madre”. Colei che scrive è Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, la quale in una lettera all’allora Segretario di Stato Card. Consalvi (da cui è tratta la presente citazione), ringrazia il pontefice che aveva compiuto il gesto di commovente bontà di accogliere la famiglia del Bonaparte nei loro stati, ed offrir loro alloggio, protezione e consolazione. Napoleone, stesso, morirà riconciliato con la Chiesa, assistito da un sacerdote corso inviatogli personalmente dal Papa.
È l’epilogo della più grande persecuzione alla Chiesa degli ultimi 200 anni ed avente come protagonisti l’imperatore francese e un monaco benedettino di Cesena - Barnaba Chiaramonti - , elevato al soglio pontificio il 14 marzo 1800 in quel di Venezia. Erano anni di violenza e di aggressione alla Chiesa, con le tragiche soppressioni a tappeto delle congregazioni e degli ordini religiosi e le confische dei beni ecclesiastici.
Gli esordi del pontificato furono segnati comunque da un clamoroso successo diplomatico: la conclusione del concordato con la Repubblica francese, il 15 luglio 1801, seguita dal concordato del 16 settembre 1803 con la Repubblica italiana. Primo paese cattolico d'Europa per popolazione e potenza, la Francia dal 1789 aveva conosciuto notevoli sconvolgimenti religiosi (proclamazione della libertà di coscienza e di culto, nazionalizzazione dei beni della Chiesa gallicana, soppressione degli Ordini religiosi, formazione di una Chiesa "costituzionale" indipendente da Roma e fondata sul principio dell'elezione dei vescovi e dei preti) seguiti da un periodo violento di decristianizzazione, associato dal 1795 ad una forma intollerante e precaria di separazione tra Stato e Chiesa. Papa di compromesso, Pio VII pose fra i suoi obiettivi prioritari il ristabilimento del cattolicesimo in Francia. Il suo spirito di conciliazione si accordava con i disegni stabilizzatori del primo console Napoleone, preoccupato di ricomporre il conflitto fra Chiesa e Stato, perché potesse giovare alla pace civile e al ritorno all'ordine, e di restaurare a proprio profitto, in un nuovo equilibrio, il precedente concordato di Bologna (1516). Siglato il 15 luglio 1801, il concordato si compone di un preambolo e diciassette articoli, aspramente negoziati per otto mesi. Esso rappresenta al contempo una notevole concessione della Santa Sede ai principi religiosi scaturiti dalla Rivoluzione, il ristabilimento della "concordia" fra Chiesa e Stato e delle principali garanzie per l'esercizio del culto, un vero "colpo di Stato" messo a segno a discapito dell'antica Chiesa gallicana e, a più lungo termine, un formidabile rafforzamento dell'autorità del papato sulle Chiese particolari. Sebbene la "religione cattolica, apostolica e romana" non fosse più la religione "del Re e del regno" ma nient’altro che "la religione della grande maggioranza [maxima pars] dei cittadini francesi": formula prettamente statistica, e non giuridica, che metteva in rapporto la situazione della religione cattolica al numero dei fedeli divenuti ormai "cittadini", tuttavia si salvaguardava in certa misura l'appartenenza individuale del capo del governo francese alla religione cattolica. Tramite questo dispositivo la libertà di coscienza e di culto delle minoranze protestante ed ebrea era garantita da qualsiasi impedimento di natura giuridica, mentre lo Stato, in quanto istituzione secolarizzata, affermava implicitamente la propria neutralità religiosa. Per converso la Chiesa cattolica recuperava la sua gerarchia, le sue chiese e le sue rendite. I vescovi sarebbero stati nominati dal governo e preconizzati dalla Santa Sede che conferiva loro l'istituzione canonica; lo Stato si assumeva l'onere del trattamento del clero, ormai stipendiato, e gli restituiva gli edifici religiosi non alienati; il clero era tenuto a prestare giuramento di fedeltà al governo. La Chiesa gallicana era annientata: il papa esigeva dal vecchio episcopato dimissioni collettive prima di procedere alla riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche e alle nuove nomine; riconosceva ugualmente ai loro acquirenti la proprietà dei beni ecclesiastici alienati.
La determinazione dimostrata da Pio VII e da Consalvi nell'applicazione pratica dei termini dell'accordo siglato il 15 luglio 1801 consolidava un'intesa fra Roma e la Francia che nel 1804 culminava nella consacrazione di Napoleone I da parte del papa nella chiesa di Notre-Dame a Parigi. Partito da Roma il 2 novembre accompagnato da molti cardinali (Antonelli, di Pietro, Braschi, Caselli, Bayane e Fesch) e da un seguito illustre (fra cui l'erudito abate Cancellieri), Pio VII fu acclamato lungo tutto il percorso del suo viaggio attraverso l'Italia e la Francia. Il quadro di J.-L. David conserva la memoria dell'incoronazione avvenuta il 2 dicembre 1804, con il papa che assiste silenzioso all'autoconsacrazione di Napoleone e poi di Giuseppina (alla quale il primo si univa in matrimonio, per l'occasione, di fronte alla Chiesa) ad opera dell'imperiale sposo. Il pontefice prolungò il soggiorno a Parigi fino al 4 aprile: visitò chiese, ospedali e musei (Visconti gli fece ammirare nel Louvre le collezioni sottratte a Roma con il trattato di Tolentino); ricevette un'entusiastica accoglienza nel Faubourg St-Antoine, quartiere popolare che era stato culla della Rivoluzione. Il lungo periplo di Pio VII, che appare una replica più felice del viaggio di Pio VI a Vienna, segnò, all'indomani della Rivoluzione, l'affermazione di un "carisma pontificale" che seppur privo di conseguenze politiche immediate o di effetti religiosi durevoli sulle popolazioni, trasformò tuttavia in profondità, nell'età democratica delle moltitudini, le relazioni del pontefice romano con le masse cattoliche. Il viaggio di ritorno a Roma si concluse con un'entrata trionfale in città, il 16 maggio 1805. La rottura tra la Francia e la Santa Sede si consumò proprio al ritorno di Pio VII nella sua sede. L'ambizione di esercitare un dominio politico, militare ed economico sull'Europa indusse Napoleone ad organizzare un "blocco continentale" contro l'Inghilterra, destinato a soffocare l'economia britannica fondata sulle esportazioni. Alla luce di questo progetto la neutralità rivendicata dal governo pontificio era impensabile. Il 15 ottobre 1805 Ancona, il porto principale degli Stati pontifici, fu occupata dalle truppe francesi: Pio VII denunciava sdegnato questo "crudele affronto". Il 15 febbraio 1806 l'armata del generale Gouvion-Saint-Cyr fece il suo ingresso a Napoli, dopo aver attraversato senza autorizzazione gli Stati pontifici: i Borbone si rifugiarono in Sicilia e il Regno di Napoli fu sottoposto al governo di Giuseppe Bonaparte, poi del maresciallo Murat, cognato dell'imperatore. Napoleone pretese inoltre che fossero espulsi da Roma tutti i rappresentanti delle potenze che gli erano nemiche: "Vostra Santità è il sovrano di Roma, ma io ne sono l'imperatore. Tutti i miei nemici devono essere i vostri". Il 21 marzo il pontefice riaffermò solennemente la propria neutralità: "Noi, Vicario di questo Verbo che non è il Dio delle dispute, ma della concordia non possiamo opporci ai doveri che ci impongono di preservare la pace con tutti, senza distinzione di cattolici ed eretici". L'imperatore mise in atto, nello stesso tempo, una politica di deliberato asservimento della Chiesa ai suoi interessi temporali e spirituali. Il 19 febbraio istituì in tutti i territori dell'Impero un "san Napoleone", oscuro martire la cui festa venne fissata il 15 agosto, giorno in cui la Chiesa celebrava l'Assunzione. Il 30 maggio 1806, con l'approvazione del debole cardinale Caprara, fu promulgato un Catechismo imperiale che esigeva dai fedeli "l'amore, il rispetto, l'obbedienza, la fedeltà, il servizio militare [e] i tributi imposti per la conservazione e la difesa dell'Impero". A questa Chiesa "napoleonizzata", in cui docili vescovi erano consacrati al ruolo di "prefetti viola", l'autorità del magistero pontificale era assoggettata agli interessi della dittatura imperiale, e una "teologia della guerra" era posta al servizio della politica francese di aggressione militare e di espansione territoriale in Europa, il papa, circondato da un Sacro Collegio risoluto in cui dominavano forti personalità come Consalvi, Pacca e di Pietro, si oppose con un categorico Non possumus. Il 17 maggio 1809 Napoleone Bonaparte emanò da Vienna il decreto con il quale spogliava il Papa dello Stato Pontificio; decreto che venne notificato a Roma proprio il 10 giugno e che presentava sette articoli, in cui si stabiliva che gli Stati della Chiesa venivano uniti all’Impero, Roma era dichiarata città imperiale e libera, ed era altresì richiesto il giuramento, anche da parte dei Pontefici, delle quattro proposizioni della Chiesa gallicana. Al momento del decreto imperiale, notificato in Roma, Pio VII, rivestito unicamente della forza di Cristo, lo dichiarò nullo, deciso a respingere ogni rendita o pensione che l’imperatore voleva assegnare alla sua persona e ai membri del Sacro Collegio, dichiarando che sceglieva una vita di miseria piuttosto che accettare il vitto da un usurpatore. Il 10 giugno il vessillo pontificio fu ammainato al Quirinale. Nello stesso giorno Pio VII promulgò e fece affiggere sulle porte delle basiliche più importanti di Roma la bolla Quam memorandum, redatta dai cardinali Pacca e di Pietro: "Per l'autorità di Dio onnipotente, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e nostra dichiariamo che tutti coloro che, dopo l'invasione di Roma e del territorio ecclesiastico, dopo la violazione sacrilega del patrimonio di S. Pietro da parte delle truppe francesi, hanno commesso a Roma e nelle Chiese contro le immunità ecclesiastiche, contro i diritti anche temporali della Chiesa e della Santa Sede, gli attentati o alcuni degli attentati che hanno suscitato le nostre giuste rimostranze […] tutti i loro artefici, fautori, consiglieri o aderenti; tutti coloro, infine, che hanno agevolato l'esecuzione di queste violenze o le hanno eseguite essi stessi, sono incorsi nella scomunica maggiore". Nove giorni dopo Napoleone scriveva al cognato, Giocchino Murat, re di Napoli: «Se il Papa, contro lo spirito del suo grado e del Vangelo, predica la rivolta e vuol servirsi dell’immunità della sua casa per far stampare manifesti, si deve arrestarlo… Filippo il Bello fece arrestare Bonifazio e Carlo V tenne a lungo in prigione Clemente VII; e questi avevano fatto anche meno».
 |
| Pio VII invitato a lasciare Roma il 10/VI/1809 |
 |
| Arresto Pio VII |
Chiese due ore di tempo. Non gli furono concesse. Chiese di essere accompagnato da alcune persone di sua fiducia. Non gli fu permesso, se non il cardinale Pacca. Con sé prese il breviario e un Crocifisso e salì in una carrozza, scortata da Radet e dai gendarmi. Fu condotto prima a Firenze, nella Certosa che dieci anni prima aveva ospitato Pio VI; poi fu prigioniero a Genova, Alessandria, Torino, Grenoble, Valenza, Avignone. Pacca, invece, fu rinchiuso nel forte di Fenestrelle, dove rimase fino al 1813. Ma in Francia il Papa divenne un peso ingombrante e fu rimandato in Italia: Nizza, Monaco, Oneglia, Finale Ligure, infine fu incarcerato nella fortezza di Savona, dove rimase fino al 1812. Con la morte di Napoleone e la Restaurazione del 1815, Pio VII tornò a Roma, dove ricostruì lo Stato Pontificio. Incaricò lo scultore Canova di trattare con il re di Francia, Luigi XVIII, la restituzione delle preziose opere rubate durante le scorrerie napoleoniche, ma riuscì a recuperare ben poco.
 |
| Trionfale ritorno a Roma di Pio VII il 24/V/1814 |
Il 18 maggio 2008: Benedetto XVI, che ha così sintetizzato il significato di quegli avvenimenti, raffigurati nella Basilica di Maria Ausiliatrice, la cui festa venne posta al 24 di maggio, data del ritorno di Pio VII a Roma, dopo il lungo esilio: “L’esempio di serena fermezza dato dal Papa Pio VII ci invita a conservare inalterata la fiducia in Dio, consapevoli che Egli, se pur permette per la sua Chiesa momenti difficili, non la abbandona mai. La vicenda vissuta dal grande Pontefice ci invita a confidare nella materna intercessione di Maria Santissima”.










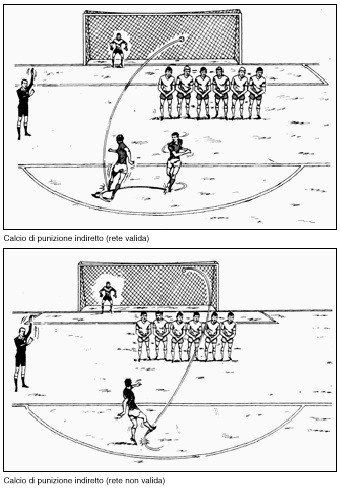

.bmp)











